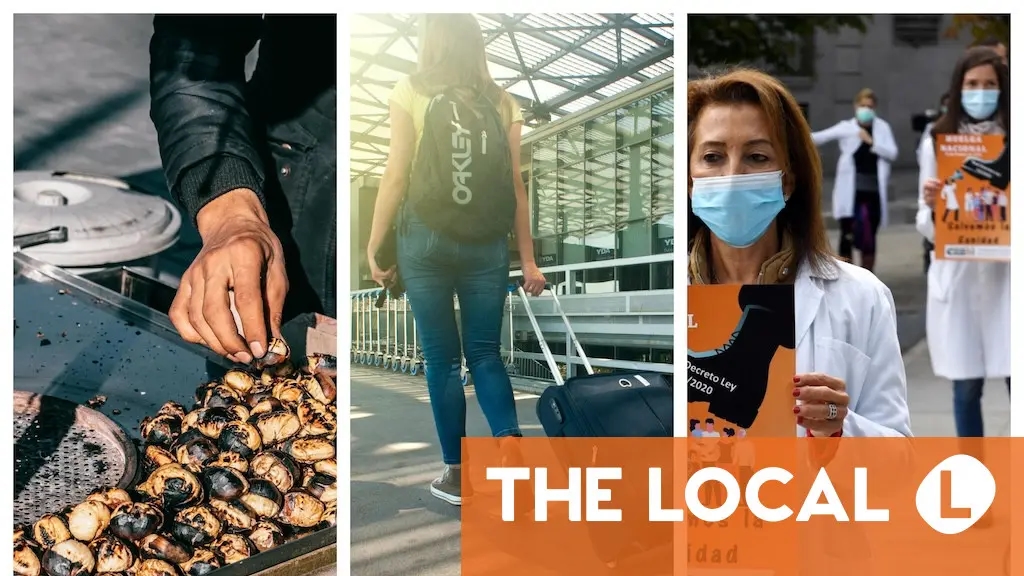Serie: Tra "Girls" e "Too Much". Reinventare l'amore in mezzo alla stanchezza tecnologica

Lena Dunham si è imposta sulla scena culturale come una delle voci più incisive della generazione dei Millennial. Girls (2012-2017) ha ritratto in modo crudo l'insicurezza lavorativa e la fragilità emotiva di un gruppo di ventenni newyorkesi. Con Too Much (Netflix), Dunham torna un decennio dopo per interrogarsi su un altro momento culturale: non più come trovare l'amore, ma come – e se mai – possa essere mantenuto in mezzo a rumore, stanchezza e iperconnettività.
In dieci episodi di poco più di mezz'ora, la protagonista Jess ( Megan Stalter ) non compie gesti eroici. La sua epopea è minima: un audio WhatsApp cancellato troppo tardi, una chiamata interrotta da un segnale debole, un video che diventa virale per errore. È in questa goffaggine digitale (così riconoscibile a qualsiasi spettatore contemporaneo) che la serie stabilisce la sua verità: l'amore non come promessa di eternità, ma come shock o inciampo.
All'inizio del XX secolo, Georg Simmel compì quella che sembrò una deviazione eccentrica: sottopose i sentimenti allo stesso microscopio usato per analizzare l'economia o la politica. In Frammenti di una filosofia dell'amore (1907), scrisse che l'amore non è un'essenza eterna, ma una forma culturale: un territorio con regole invisibili, convenzioni e persino una propria grammatica.
In Too Much , questa vertigine moderna si incarna nel digitale: l'intimo esposto alla luce spietata delle reti. In un episodio, un collega confessa che prima di fare coming out, caricava video rappando testi sessisti per convincere (e convincere se stesso) della sua eterosessualità . Non era musica: era una maschera, una performance pensata per adattarsi, per comunicare a un ipotetico pubblico la sua appartenenza. Ciò che un tempo veniva negoziato attorno al tavolo di famiglia ora si svolge davanti alla telecamera di un cellulare ; lo sguardo non è più quello dei genitori o dei vicini, ma quello di un pubblico globale e anonimo.
Simmel aveva già avvertito: l'amore classico, nella tradizione platonica, non era rivolto all'individuo concreto, ma a ciò che incarnava: la bellezza, la virtù, l'eterno. L'amore moderno, invece, rischia di concentrarsi sull'irripetibile. Ama ciò che non può essere ripetuto. Questo gesto è anche una condanna: l'unica cosa che sostiene la relazione è la fragilità delle nostre biografie di fronte all'incessante mormorio delle convenzioni.
 Girls ha vinto i premi come migliore serie comica musicale e migliore attrice.
Girls ha vinto i premi come migliore serie comica musicale e migliore attrice."Voglio un mondo in cui l'amicizia sia considerata una forma di romanticismo", scrive il poeta queer Alok Menon in "The Reinvention of Love" (Siglo XXI, 2025), il nuovo libro del sociologo Joaquín Linne . Questo recente lavoro esplora, attraverso l'autoetnografia, come ci innamoriamo, facciamo sesso, coltiviamo amicizie e ci prendiamo cura degli animali domestici nell'era di Tinder.
Lena Dunham mette in scena questo nuovo paesaggio emotivo. Ogni notifica, ogni messaggio letto o ignorato, ogni emoji inviata o salvata funge da prova d'identità. Jess inventa rituali contemporanei: spiare il nuovo compagno del suo ex su Instagram , registrare videolettere che non invierà mai, essere intrappolata tra l'ansia e il bisogno di connessione.
 La reinvenzione dell'amore (XXI secolo), di Joachim Linne.
La reinvenzione dell'amore (XXI secolo), di Joachim Linne.Dal 2020, sotto l'influenza della pandemia, Joaquín Linne si è dedicato a indagare il mondo delle app di incontri . Quella promessa iniziale di efficienza (basata su compatibilità e istantaneità) appare ora invertita: profili ambigui, algoritmi che organizzano il desiderio con la freddezza di un foglio di calcolo, match che non si materializzano mai. Spesso, la distanza geografica, la stanchezza o le difficoltà economiche interrompono la coreografia del desiderio: dopo il match, i corpi non si incontrano ; rimangono bloccati sullo schermo, a malapena sostenuti da una chat. In breve, l'algoritmo impone anche il formato.
Nel frattempo, le vecchie istituzioni (matrimonio, convivenza, famiglia) restano, come mobili ereditati che nessuno vuole buttare via. Forse non per nostalgia, ma per necessità: perché anche la vertigine vuole un posto dove appoggiare la fronte.
Lena Dunham torna alle sue vecchie abitudini: amicizie che rasentano il romanticismo, legami queer che sfidano le rigide categorie, corpi che non rientrano negli schemi precostituiti. La sua narrazione riflette un profondo cambiamento culturale: l'emergere di nuove sessualità e generi che non solo complicano il modo in cui amiamo, ma anche il modo in cui raccontiamo l'amore. Ma non lo dice subito. Lo lascia insinuarsi in piccole scene, in dettagli apparentemente banali, come quando Jess copre Felix con una coperta, quel gesto protettivo imparato durante l'infanzia e che qui pesa con tutta l'intensità dell'intimità.
 Serie Too Much. Netflix
Serie Too Much. NetflixQuello sguardo mi ricorda Raymond Carver , un esperto nel soffermarsi sui resti dell'amore senza cercare di definirlo. I suoi racconti mettono insieme dettagli minimi: una carezza che aleggia nell'aria, il film muto di una relazione. L'amore descritto da Carver non scorre; gocciola, trasuda, rimane ai margini, come emozioni a cui nessuno sa dare un nome.
Il titolo della serie dice tutto: Jess è sia eccesso che condanna. Ma è anche una frase che apre a un'altra interpretazione: "Sei troppo", le dice Felix, e non è un rimprovero ma un complimento. Quell'intensità, quella sovrabbondanza, è ciò che alla fine lo fa innamorare. Come in Carver, il fallimento dell'amore non annulla il sentimento; lo trasforma, lo rende malinconico e resiliente. Un sentimento che sopravvive alle strutture che cercano di incasellarlo e contenerlo.
 Raymond Carver.
Raymond Carver.Amore e cultura sono in un continuo tira e molla. L'amore si scontra con le strutture che esso stesso ha contribuito a creare. In quest'epoca di algoritmi che misurano i desideri, di sessi che si moltiplicano e di legami saturi di ipercomunicazione, Demasiado non si preoccupa di rispondere alla domanda se l'amore romantico sia ancora possibile. Piuttosto, si presenta come uno specchio oscuro e un monito: una relazione, qualunque essa sia, vive all'interno di una macchina di interferenze.
Simmel credeva che l'amore fosse una forma culturale. I Joy Division dicevano che ci avrebbe fatto a pezzi. Dunham non dice nulla di tutto ciò: lo mette in scena in mille pezzi. La domanda, forse, non è se l'amore sopravviverà, ma quali nuove forme inventeremo per dargli un nome.
Maricel Cioce è una sociologa culturale, insegnante e scrittrice.
Clarin